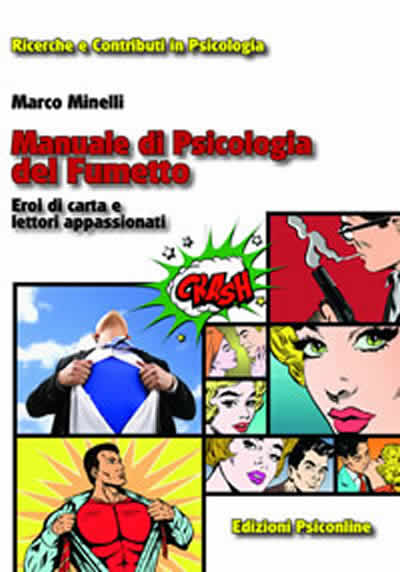
Introduzione
I. Cenni sulla storia della letteratura a fumetti
II. Cenni sulle tecniche di linguaggio dei fumetti
III. Le classificazioni descrittive dei periodici a fumetti
IV. Il fumetto come strumento di ricerca in psicologia
V. Le ricerche psicologiche sui fumetti
VI. Contenuto dei fumetti e fantasie dei lettori
VII. Meccanismi di difesa che si attivano durante la lettura dei fumetti
VIII. Uomini e donne di carta
IX. Dylan Dog: L’indagatore dell’incubo
X. Linguaggio iconico ed attività onirica.
E’ ormai più di un secolo che i fumetti sono di fatto una delle letture più frequenti di bambini, adolescenti ed anche adulti. In mancanza di una specifica disciplina di “fumettologia”, improbabile anche per il futuro, gli studi sul fumetto sono stati condotti nell’ambito della semiologia, dell’antropologia, della sociologia, della pedagogia e della psicologia.
L’analisi psicologica dei fumetti assume molta importanza quando ci si accorge che essi possono essere considerati come uno specchio della società in un determinato momento storico. Infatti gli eroi di carta riflettono in ogni epoca, i bisogni, le caratteristiche, i valori e le fantasie che rappresentano quel che prevale nelle strutture della personalità delle nuove generazioni.
Ricostruendo la storia del fumetto nel novecento ed individuando le categorie di generi narrativi è possibile comprendere attraverso quali meccanismi psicodinamici i lettori dei singoli generi e gli affezionati ai singoli personaggi strutturano il loro interesse e costruiscono le loro difese per poter continuare a fruire del singolare piacere offerto da questi albi che sintetizzano il linguaggio verbale della letteratura e quello per immagini proprio del cinema.